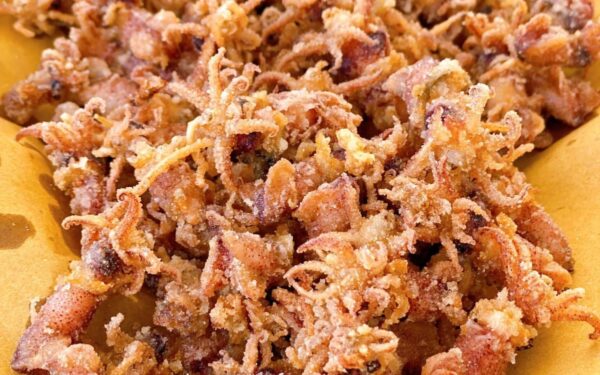Un’era di cambiamenti che nessuno ha visto arrivare, la nuova vita di Palazzo Butera a Palermo
Scopri come Palazzo Butera a Palermo è rinato come hub culturale e custodisce segreti storici e moderni esclusivi

Il Palazzo Butera, situato nel cuore della Kalsa a Palermo, ha finalmente compiuto la sua metamorfosi: da sontuosa residenza nobiliare dei Branciforti a laboratorio culturale d’eccellenza grazie alla visione dei collezionisti Massimo e Francesca Valsecchi.
Le origini risalgono al 1692, ma è nel Settecento che l’edificio prende forma: l’architetto Giacomo Amato cura l'esterno, mentre Ferdinando Fuga firma gli interni . L'incendio del 1759 non ferma la grandiosità: anzi, motiva un restauro monumentale con decorazioni rococò e neoclassiche guidate da Martorana e Fumagalli.
Nel 2016, un ambizioso progetto di restauro — affidato all’architetto Giovanni Cappelletti — restituisce al palazzo la sua antica maestosità e lo trasforma in un open space di arte, storia e innovazione, con installazioni contemporanee al piano terra e una panoramica collezione al primo piano. La passerella in vetro retroilluminato, inserita tra gli ambienti storici, è un esempio di dialogo estetico tra antico e moderno.
Arte, memoria e inclusione urbana
Oggi il Palazzo Butera non è solo uno spettacolo barocco: è divenuto un motore di rigenerazione culturale e sociale per i quartiers storici di Palermo.
Attraverso la Fondazione Palazzo Butera, la dimora è aperta a tutti: ospita eventi, seminari e residenze culturali, facendo dialogare arte locale e internazionale. La collezione Valsecchi, capace di viaggiare tra il contemporaneo e l’antico, include opere di Ferretti, Tremlett, Carracci, Burne-Jones e altri, testimonianza di un legame forte tra Palermo e l’Europa.
Anche la scelta di aprire le porte durante Manifesta 12, evento che nel 2018 incoronò Palermo Capitale della Cultura Europea, ha consacrato il palazzo come epicentro di un rinascimento urbano, all’avanguardia e inclusivo.
Architettura, meraviglia e tecnologia
L’intervento è stato improntato a “sottrazione e leggerezza”, con elementi come scala di vetro, passerella in ferro e vetro e serramenti minimalisti, che non sovrastano ma valorizzano la struttura barocca .
I colori originari — rosa, indaco, verde ceylon — sono stati riportati alla luce nei lambris coperti di ridipinture, restituendo un'atmosfera autentica del Settecento palermitano.
Il prospetto principale, affacciato sul Foro Italico e sulla cosiddetta “Passeggiata delle Cattive”, domina ancora oggi il golfo e riconferma il ruolo scenico del palazzo nella skyline cittadina.
Curiosità
Sapete perché i palermitani chiamano quella terrazza “Passeggiata delle Cattive”? Il termine deriva da captivae — “prigioniere” del lutto — perché era il luogo dove le vedove si recavano a camminare, isolate dal resto della città, per il loro dolore