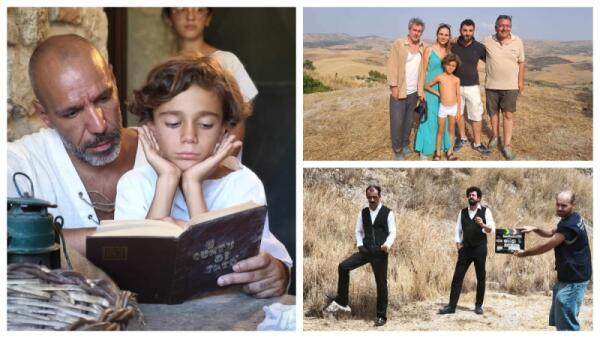Cosa non ti hanno mai detto su questa chiesa di Catania: la trovi in via Etnea e nasconde una vicenda sorprendente
Scopri San Michele ai Minoriti, capolavoro barocco di Catania: storia, arte, campanile e curiosità straordinarie!

Nobiltà e ricostruzione d’élite
La Chiesa di San Michele Arcangelo ai Minoriti, uno dei capolavori del tardo barocco catanese, si affaccia imponente sulla via Etnea, cuore pulsante della città. Fu edificata tra il 1771 e il 1787, su progetto dell’architetto Sebastiano Ittar, che ne concepì la sobria eleganza ispirandosi ai canoni neoclassici emergenti. L’opera fu poi completata da Francesco Battaglia, tra i principali artefici della ricostruzione post-terremoto del 1693, tragico evento che distrusse gran parte del centro storico.
I Chierici Regolari Minori, noti come Caracciolini, si stabilirono a Catania già nel 1625, favoriti dal vescovo Innocenzo Massimo, figura centrale nella restaurazione religiosa e culturale del XVII secolo. Ma fu il nobile Giambattista Paternò, appartenente a una delle famiglie più influenti della città, a donare vaste proprietà terriere e fondi per la costruzione del complesso conventuale. Questo gesto non fu solo di pietà religiosa, ma anche una strategia politica per rafforzare il prestigio della famiglia e legarla ai nuovi ordini ecclesiastici impegnati nell’educazione e nell’assistenza.
Grazie a questi contributi, i Caracciolini si insediarono nel pieno centro urbano, affiancando la loro chiesa al palazzo già esistente, trasformandolo in un convento monumentale e diventando un punto di riferimento spirituale, sociale e intellettuale per generazioni di catanesi.
Architettura sacra e dettagli artistici
L’aspetto più sorprendente della chiesa è la facciata in calcare bianco di Siracusa, a due ordini, sobria ma maestosa, decorata con statue lapidee, colonne ioniche e un grande portale d’ingresso incorniciato da motivi vegetali scolpiti. Questo contrasto tra il bianco della pietra e il nero lavico del basolato catanese sottolinea il connubio fra grazia e forza, tipico del barocco siciliano.
L’interno è strutturato su pianta a croce greca, una rarità per l’epoca, ed è sormontato da una cupola ottagonale interamente rivestita da piastrelle azzurre in maiolica, che riflettono la luce dando all’ambiente un senso di levità. L’organo Serassi del 1858, proveniente da Bergamo, è uno dei pochi strumenti ottocenteschi funzionanti ancora oggi in Sicilia, con oltre 1 200 canne.
Di grande rilievo sono anche le acquasantiere in marmo scolpite a mano, la scalinata a doppia rampa con 13 gradini simbolici e gli altari laterali, che ospitano opere del catanese Marcello Leopardi e del pittore fiammingo Guglielmo Borremans, autore anche di affreschi nella chiesa di San Benedetto. Tra le tele più venerate spiccano quelle dedicate a Sant’Agata, San Francesco Caracciolo (fondatore dell’ordine) e all’Annunciazione, tutte ispirate a modelli iconografici settecenteschi, ma con forti tratti locali.
Rinnovamento urbano e funzione civile
Il convento adiacente, un tempo cuore pulsante della vita caracciolina, fu espropriato nel 1866, in seguito alle leggi sull’eversione dell’asse ecclesiastico post-unitario. Divenne allora sede della Provincia e successivamente della Prefettura, funzione che conserva tutt’oggi. Questo passaggio da luogo di clausura a centro amministrativo testimonia il cambio radicale di funzione urbana e sociale dell’architettura religiosa nella Catania moderna.
Nel 1869, per adattare la chiesa ai nuovi livelli stradali determinati dall’urbanizzazione ottocentesca della via Etnea, si intervenne architettonicamente sulla facciata, aggiungendo una scalinata in pietra lavica che oggi rappresenta uno dei suoi tratti distintivi. Questi lavori modificarono anche il livello interno del sagrato e comportarono l’eliminazione di alcune cappelle laterali, dando al complesso la configurazione che vediamo oggi.
Oggi l’ex convento ospita uffici pubblici e mostre temporanee, mentre la chiesa continua ad accogliere fedeli e turisti. È uno dei pochi luoghi in cui sacralità, istituzione e arte coesistono, rappresentando un tassello fondamentale nella narrazione storica di Catania.