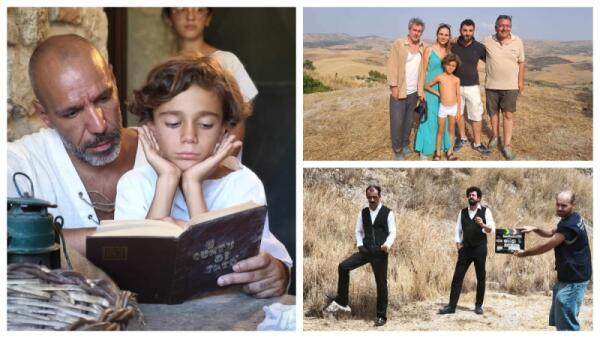La verità che ha lasciato Catania a bocca aperta: i Monti Rossi di Nicolosi e il mistero che non ti aspettavi
Scopri i Monti Rossi di Nicolosi: gemelli vulcanici nati nel 1669 e la curiosità che ha cambiato Catania per sempre!

Nascita devastante dei Monti Rossi
I Monti Rossi, due imponenti coni piroclastici gemelli situati appena a nord di Nicolosi, rappresentano uno degli episodi vulcanici più sconvolgenti della storia dell’Etna e di Catania. Si formarono nel corso dell’eruzione del 1669, la più distruttiva mai registrata sul vulcano, sia in termini di estensione che di impatto socio-urbano. L’attività eruttiva iniziò nella notte tra il 10 e l’11 marzo 1669, quando si aprirono lunghe fratture eruttive a sud del cratere centrale, nei pressi di Nicolosi. In poche ore, dalla terra squarciata iniziarono a fuoriuscire fontane di lava e cenere, che diedero forma ai due colli rossi, oggi noti come Monti Rossi.
Questi coni, dalla forma perfettamente simmetrica, furono chiamati così per via del colore intensamente rossastro dei materiali vulcanici espulsi, ben visibili anche da Catania nelle notti infuocate del Seicento. In dialetto vennero soprannominati “Munti Russi”, le “montagne rosse”. Durante i 122 giorni di attività, la lava fuoriuscita da questi coni invase una vasta porzione del versante meridionale dell’Etna. I materiali eruttati, prevalentemente scorie, lapilli e cenere, ricoprirono il territorio creando un paesaggio infernale, segnato da fumi, esplosioni e boati continui che terrorizzarono intere comunità locali.
Giganti che modificarono il volto di Catania
La colata lavica del 1669, partita dai Monti Rossi, è ancora oggi la più lunga e distruttiva dell’intera storia recente dell’Etna: si calcola un'estensione di circa 17 chilometri, dal punto di emissione fino al mare. Durante il suo lento e inesorabile percorso, la lava inghiottì campagne, paesi interi come Malpasso (oggi Belpasso), Mompilieri, San Pietro Clarenza, e si spinse fino alle mura occidentali della città di Catania. Qui, dopo aver circondato e lambito le mura del Castello Ursino, la colata raggiunse il porto, distruggendo moli e abitazioni. Secondo fonti storiche, oltre 10.000 persone furono costrette ad abbandonare le loro case.
Questa eruzione ebbe un impatto profondo anche sull’idrografia urbana. Il fiume Amenano, che scorreva in superficie attraversando Catania, venne interrato per sempre, scomparendo sotto decine di metri di lava. La stessa sorte toccò al Lago di Nicito, un bacino d’acqua dolce molto frequentato dai catanesi, che scomparve del tutto. La geografia della città fu completamente riscritta, con quartieri nuovi che nacquero sulle colate solidificate. L’eruzione del 1669 è considerata uno spartiacque nella storia della città, un trauma vulcanico che ancora oggi vive nella toponomastica, nell’urbanistica e nella memoria collettiva.
Oggi: Monti Rossi come parco e monito naturale
I Monti Rossi, da catastrofe naturale a monumento paesaggistico. Oggi sono parte integrante della Pineta dei Monti Rossi, un polmone verde curato dal Comune di Nicolosi, molto frequentato dai catanesi per passeggiate, escursioni e attività all’aria aperta. I due coni, visibili da buona parte del versante sud dell’Etna, ospitano sentieri naturalistici, aree attrezzate e punti panoramici, oltre a spazi per eventi culturali ed educativi, come quelli promossi dall’Osservatorio Vulcanologico Etneo.
Sotto la superficie, le colate piroclastiche dell’eruzione del 1669 hanno dato forma anche alla famosa Grotta delle Palombe, esplorata per la prima volta nel 1823. Si tratta di un tubo lavico secondario di circa 80 metri, oggi visitabile solo con attrezzature speleologiche. Il sito rappresenta un laboratorio naturale per studiosi e appassionati di vulcanologia, oltre che un punto di attrazione per il turismo sostenibile. Per i catanesi, i Monti Rossi sono un luogo di memoria e rinascita, dove la distruzione del passato convive con la bellezza silenziosa della natura riconquistata.