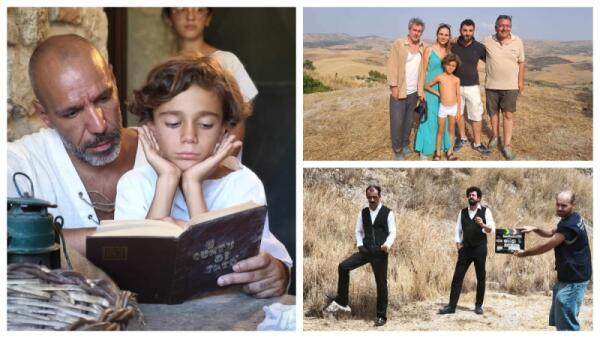Una storia che lascia senza parole: il borgo siciliano che ha riscritto il destino degli uomini
Tra laghi sulfurei, dei Palici e dolci di Santa Febronia, Palagonia incanta i catanesi con storia antica e curiosità incredibili!

Calderone di miti, vulcani e dei gemelli
L’antica Palagonia, conosciuta nei tempi antichi come Paliké, fu fondata nel 453 a.C. dal condottiero siculo Ducezio, carismatico capo della resistenza indigena contro l’espansione greca. Questo luogo, situato a sud dell’attuale centro abitato, fu scelto per la sua vicinanza ai celebri laghetti sulfurei di Naftia, piccoli crateri gorgoglianti immersi in un paesaggio lavico, dove – secondo la mitologia sicula – nacquero i gemelli divini Palici, figli del dio Adranos e della ninfa Etna. I Palici erano venerati come protettori degli oppressi e degli schiavi, a cui offrivano giustizia divina: i giuramenti si compivano proprio presso i laghi, dove chi mentiva sarebbe stato punito dalle acque sulfuree, risucchiato nel ventre della terra.
L’importanza religiosa e politica del sito era tale da attirare ambascerie, mercanti e pellegrini da tutta la Sicilia, rendendolo uno dei centri di culto più importanti dell’Isola fino all’arrivo dei Greci e, successivamente, dei Romani. Anche gli autori classici come Diodoro Siculo e Virgilio citano i Palici, rafforzando la fama ultraterrena di questo luogo. Oggi, quell’area – nota come Contrada Rocchicella – è studiata e monitorata dall’INGV di Catania per via delle continue emissioni gassose di origine vulcanica, segno che l’Etna continua a “parlare” anche da qui. Una leggenda vuole che nei giorni di festa, se si ascolta con attenzione, si possa ancora udire un sussurro di vapore provenire dal sottosuolo, come un eco degli antichi oracoli siculi.
Principi Gravina, fortezze perdute e cupole maiolicate
Nel corso del medioevo, Palagonia fu più volte devastata da terremoti e incursioni saracene, fino a diventare un feudo disabitato. Fu nel 1450 che i principi Gravina, famiglia aristocratica tra le più potenti della Sicilia orientale, ottennero dal re Alfonso d’Aragona l’autorizzazione a ripopolare il feudo e a costruire un nuovo centro urbano. Nacque così la “nuova” Palagonia, dotata di castello, cinta muraria, bastioni difensivi e una piazza centrale di impianto rinascimentale. Le cronache del tempo descrivono un “castello con quattro torri e sale da ballo”, sale degli specchi, un giardino pensile con agrumi e fontane, una rarità assoluta per il tempo.
Di quel fasto oggi rimane poco, ma la Basilica di Santa Maria del Carmine custodisce una parte importante di quell’eredità. La sua cupola in maioliche giallo-verdi, visibile a chilometri di distanza, è tra le più affascinanti della provincia. L’interno ospita altari barocchi intagliati in marmi policromi, stemmi nobiliari, reliquiari d’argento e una tribuna con organo ligneo del Settecento. La chiesa fu ricostruita più volte dopo i terremoti del 1693 e del 1818, ma conserva ancora oggi l’impianto originario commissionato dai Gravina. Curiosamente, molte famiglie catanesi di origine palagonese conservano ancora in casa frammenti di maiolica antica, tramandati come reliquie architettoniche del borgo originario.
Santa Febronia: eremo rupestre, martirio e… fotografia d’autore
Poco fuori dal centro urbano, a circa 5 chilometri, si erge uno dei santuari rupestri più affascinanti della Sicilia orientale: l’Eremo di Santa Febronia, ricavato all’interno di una grotta preistorica e successivamente trasformato in basilica rupestre tra il VI e il VII secolo. Questo luogo suggestivo, circondato da fichi d’India e lave antiche, era già utilizzato come necropoli nell’età del Rame. Con l’avvento del cristianesimo, divenne un luogo di culto per la giovane martire Febronia, che secondo la tradizione fu torturata e decapitata per non aver rinunciato alla sua fede. All’interno si possono ancora ammirare affreschi bizantini, tra cui un raro Cristo Pantocratore a braccia alzate e la scena cruenta del martirio della santa.
Ogni anno, nel mese di luglio, una folla di fedeli catanesi e pellegrini locali accompagna in processione la statua della patrona tra canti, danze e lancio di petali. Ma il simbolo più dolce di questa devozione sono i “biscotti di Santa Febronia”, dolcetti a forma di bambola realizzati a mano secondo una ricetta tramandata oralmente: farina, strutto, uova, buccia di limone, e una spruzzata di vermouth, cotti fino a doratura e ricoperti di zucchero o glassa. Curiosamente, nel primo Novecento, il celebre fotografo catanese Giovanni Crupi, in visita a Palagonia, immortalò la festa di Santa Febronia in una serie di lastre oggi conservate a Roma, testimonianza tangibile di una devozione ancora vivissima.