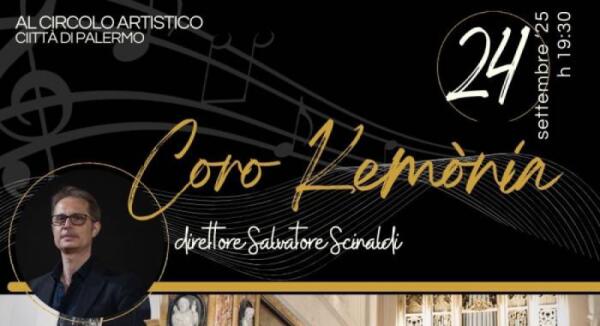Il guardiano silenzioso che da secoli sfida lo Stretto e che pochi conoscono
A Messina il faro di Capo Peloro veglia sullo Stretto: tra miti di Scilla e Cariddi, panorami unici e una curiosità che pochi conoscono.

All’estremità nord-orientale della Sicilia, laddove lo Stretto di Messina mostra la sua forza primordiale, si erge il faro di Capo Peloro. Non è solo una torre luminosa: è un guardiano millenario, custode di miti, leggende e rotte marine che hanno fatto tremare naviganti e imperatori. Con la sua posizione privilegiata, questo faro racconta una storia in cui si intrecciano geografia, mitologia e ingegneria.
Un faro tra mito e storia
Capo Peloro, noto già ai Greci e ai Romani, era considerato uno dei luoghi più pericolosi della navigazione mediterranea. Secondo il mito, proprio qui dimoravano Scilla e Cariddi, i due mostri marini che rendevano lo Stretto una trappola mortale. Nel corso dei secoli, da Omero a Virgilio, questo lembo di Sicilia è stato evocato come simbolo di sfida e di paura.
Il faro che oggi domina Capo Peloro è l’erede di una lunga tradizione di torri di avvistamento e segnali luminosi. L’attuale struttura, alta 37 metri, risale alla seconda metà dell’Ottocento, quando la Marina italiana decise di potenziare la rete di fari lungo le coste. Con la sua luce, visibile a oltre 20 miglia marine, guidava i naviganti attraverso correnti insidiose e vortici imprevisti.
Il guardiano dello Stretto
Il faro di Capo Peloro non è soltanto un presidio tecnico: è un simbolo identitario per la città di Messina. Da secoli accompagna le storie di pescatori, marinai e popolazioni locali che lo hanno sempre visto come un punto di riferimento sicuro. Dal suo piedistallo si possono ammirare panorami unici: le coste calabresi a un passo, le acque agitate dello Stretto e le spiagge bianche di Torre Faro.
Negli ultimi anni il faro, affidato al Fondo Ambiente Italiano (FAI) nell’ambito del progetto “I Luoghi del Cuore”, è stato oggetto di iniziative di valorizzazione e aperture straordinarie. È così tornato a vivere come luogo di cultura e memoria collettiva, non solo come struttura tecnica per la navigazione.